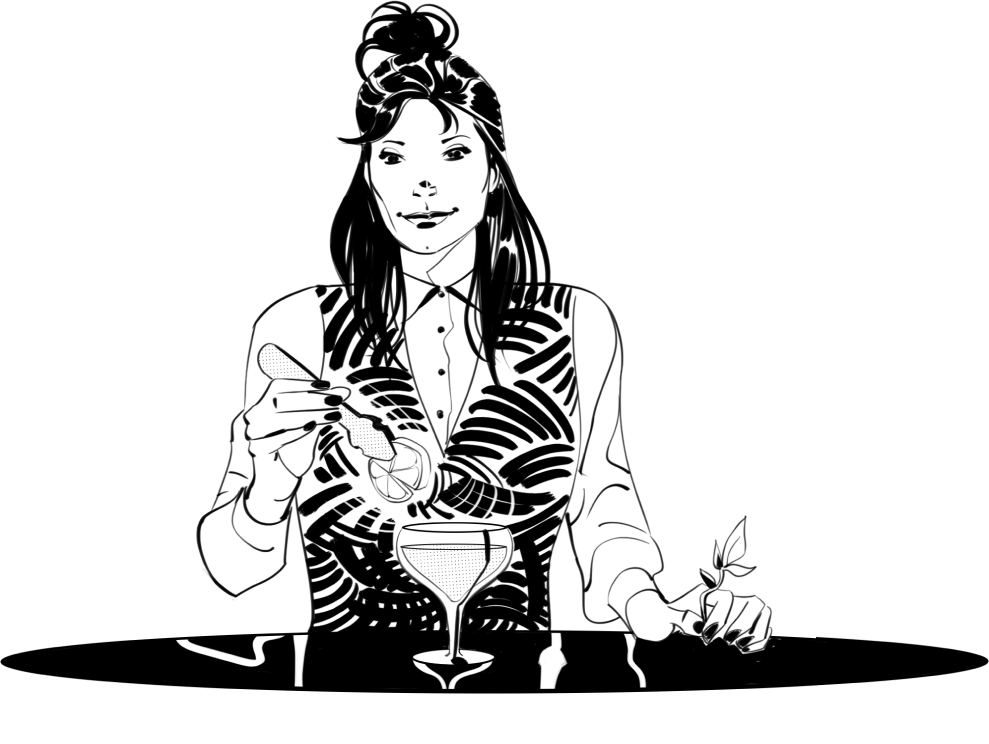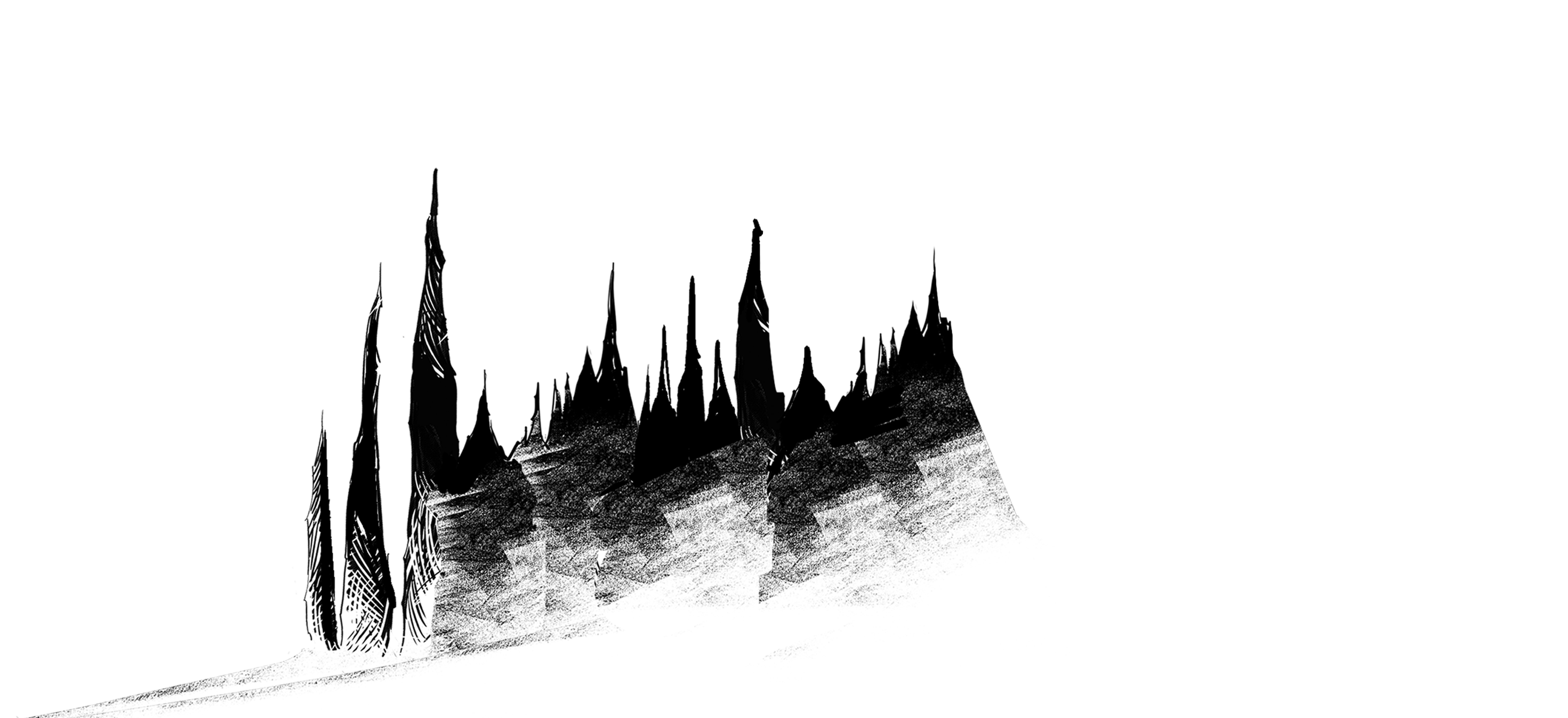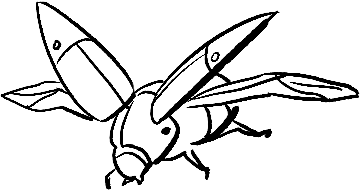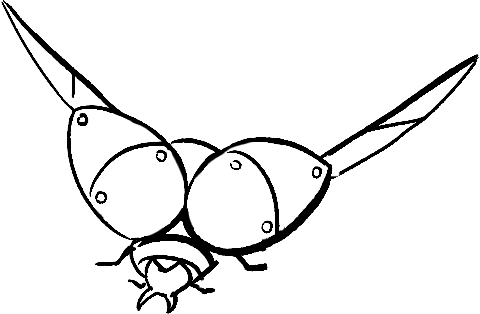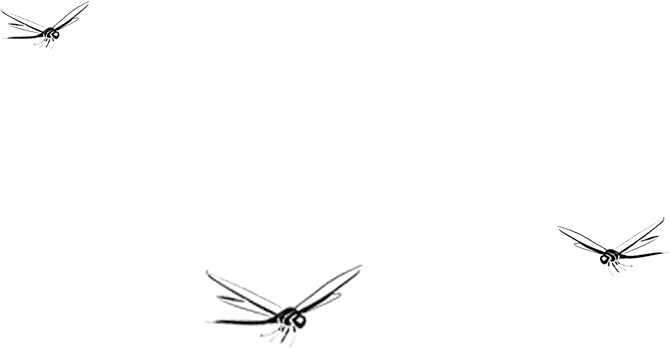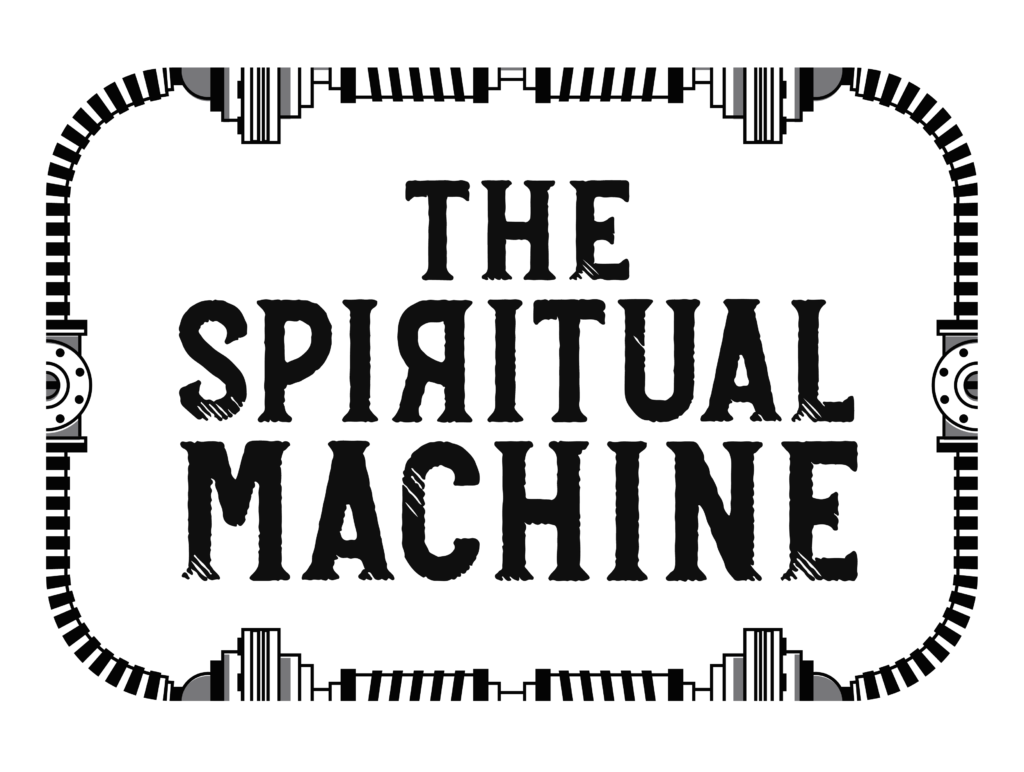Come si caratterizzano gli amari italiani

Le spezie, le scuole, i sapori La Penisola italiana può vantare una vastissima tradizione nella produzione di liquori amari. Le ragioni di questa ricchezza sono dovute a diversi fattori, il primo geografico. L’Italia è infatti una sottile striscia di terra che corre per 1200 km dalle Alpi fino al Sud del Mediterraneo. Può vantare quindi una grande quantità di ambienti e microclimi, in cui si sviluppano altrettante piante aromatiche, diverse per sapore e caratteristiche. Proprio per queste caratteristiche, la nostra Penisola ha anche subito meno gli effetti della piccola era glaciale che l’Europa ha attraversato a cavallo fra il XIV e XIX secolo. Ciò ha permesso di conservare la maggior parte della flora presente sul nostro territorio. Infine da un punto di vista geopolitico la presenza di diversi Stati e di numerosi monasteri ha ulteriormente ampliato le differenze fra i prodotti della liquoristica. Consentendo di conservare prodotti tipici di ogni realtà senza uniformare i gusti. Si possono individuare tre famiglie di liquori amari, ciascuna caratterizzata da ingredienti peculiari e da usi storici differenti. Ancora oggi possono essere riconosciute nelle moderne produzioni. Amari alpini I liquori amari appartenenti a questa famiglia provengono dalle regioni alpine più fredde della penisola italiana. Motivo per cui sono spesso di gradazione alcolica elevata, con lo scopo di riscaldare le persone durante i lunghi inverni nevosi. Le piante amare utilizzate per questi liquori sono principalmente la genziana, la cui radice cresce in ambiente alpino e appenninico, e l’assenzio. A queste piante si aggiungono spesso menta, achillea e ortica, presenti in questi ambienti freddi e inospitali. Le aggiunte di spezie dolci come la cannella e i chiodi di garofano servivano ad ammansire il gusto netto e deciso di questi amari alpini. Amari abbaziali Durante il Medioevo maneggiare erbe e piante aromatiche poteva facilmente essere additato come stregoneria. Motivo per cui queste tradizioni poterono sopravvivere solo grazie ai monaci. Nei loro conventi erano infatti legittimati all’uso di queste arti, protetti dal loro ruolo nella società. Le erbe usate per questi tipi di amari avevano uno scopo puramente medicinale. Motivo per cui erano spesso estratti di una singola pianta oppure decisamente rimedi composti da centinaia di erbe differenti, per elisir deputati alla cura intera del corpo. Cardo mariano, rabarbaro e tarassaco sono alcuni degli ingredienti che possiamo trovare in queste tipologie di liquori amari. Amari mediterranei Anche in questa parte dell’Italia gli amari hanno avuto per secoli funzione puramente medicinale. Ricordiamo che proprio a Salerno nasce la prima università di Medicina di Europa. Da questa fucina di sapere derivano la maggior parte delle conoscenze sulla distillazione e macerazione delle erbe. Ingredienti principali di questi amari sono scorze di agrumi, frutta secca, miele e anice e semi di finocchio. Vengono adoperati per la loro funzione digestiva e dissetante. Contrariamente alle due precedenti tipologie di amari, gli amari mediterranei sono molto zuccherati. D’altronde rispecchiano la pasticceria dolce tipica delle regioni del Sud Italia. Oggi le divisioni non sono più così nette fra queste famiglie di liquori amari. Tuttavia è sempre utile e interessante tenerle a mente, soprattutto quando si vuole creare un amaro da zero. Se stai pensando di creare il tuo liquore amaro, prenota una consulenza gratuita e noi di The Spiritual Machine.Sapremo trasformare la tua idea di amaro in un prodotto unico.
5 cocktail a base Vermouth per l’aperitivo di Natale

I cocktail a base Vermouth da bere sotto l’albero Rosso caldo e speziato, bianco floreale e delicato, dry fresco e intrigante. In qualunque versione il vermouth è sempre un ottimo compagno per l’aperitivo, ancora meglio se per quello del cenone di Natale. Un cocktail con questo vino aromatizzato, ricco di storia e tradizione, non può che fare colpo sui vostri ospiti. Ecco alcune ricette sfiziose da provare. Milano-Torino Il più classico degli aperitivi a base vermouth è proprio lui. L’unione fra Vermouth di Torino, il grande classico il Punt e Mes, e Bitter di Milano, il Campari. Miscelati in parte uguali in un bicchiere Old Fashioned con abbondante ghiaccio, da servire con la classica fettina di arancia. In alternativa con qualcosa di più natalizio, come la stessa arancia disidratata in forno, oppure chiodi di garofano o cannella. Ideale anche per i “pigri” della miscelazione: basta fare una caraffa prima dell’arrivo degli ospiti e poi servirlo nei bicchieri pieni di ghiaccio. Ha un gusto amaro e deciso. Americano Anche in questo caso Vermouth rosso, Bitter e uno splash di soda, sono gli ingredienti di questo cocktail. Rimane caldo e speziato, meno aggressivo del Milano-Torino. Si abbina perfettamente con aperitivi a base di formaggio, grazie alla sua nota agrumata intensa e al suo calore che puliranno la bocca. Provare per credere. La classica guarnizione con la fetta d’arancia può essere sostituita con qualche spezia di richiamo al Vermouth scelto. Ad esempio anice stellato o dello zenzero candito. Manhattan Vermouth rosso e rye whisky si mescolano in questo pilastro della miscelazione internazionale. Il Manhattan necessita di un pochino più di manualità se volete servirlo come aperitivo, ma vale tutta la fatica. In un mixing glass colmo di ghiaccio si versa una goccia di angostura, a cui si uniscono 5 cl di rye whisky e 2 cl di vermouth rosso. Una delicata mescolata e poi si versa in una coppetta ben fredda, con la classica guarnizione di ciliegia al maraschino. Per i non puristi è anche autorizzata la buccia di limone. La presenza del whisky e del vermouth richiamano piatti di carne, e perché no, anche qualche stuzzichino piccante. Gibson Un cocktail secco e per chi non teme le gradazioni spinte. In un mixing glass colmo di ghiaccio si uniscono 6 cl del vostro gin preferito e 1 cl di vermouth dry. Una leggera mescolata e il tutto si versa in una coppa ben fredda, immancabile la guarnizione con la cipollina. Se la vostra cena sarà a base di pesce, questo cocktail secco ma aromatico grazie al tocco di vermouth dry, sarà l’aperitivo perfetto. Vermuttino Questo non si può nemmeno definire cocktail, ma fa parte della storia dell’aperitivo torinese, città natale di questo vino aromatizzato che ha fatto il giro del mondo. In tutti i bar della città si serviva un bicchierino di vermouth accompagnato con uno splash di soda. Era l’aperitivo di tutti i torinesi, un momento conviviale rubato al lavoro da operaio o da impiegato. Servito in piccoli bicchieri, anche con un cubetto di ghiaccio. Può essere un piccolo benvenuto per i vostri ospiti, accompagnato da qualche stuzzichino. In questo caso il Vermouth deve essere all’altezza del compito, essendo l’unico ingrediente di questo non-cocktail. Sul nostro shop potete trovare vermouth artigianali, lontani dai soliti aperitivi mainstream, capaci di raccontare una storia all’interno dei vostri cocktail. Visitate il nostro shop per brindare al Natale con un vermouth dal sapore unico.
I 5+1 principali tipi di gin

Le principali tipologie di gin La definizione di gin è stabilita dal Regolamento Europeo 787/2019, che definisce questa bevanda come: – ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro di alcol di origine agricola – dalla gradazione minima di 37,5% vol/vol E’ permesso inoltre l’uso di sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche, solo nella misura in cui queste lascino il ginepro come nota aromatica dominante. La menzione dry è riservata solo a quei gin con un contenuto di zucchero inferiore a 0,1 g/l. Queste regole poco stringenti, hanno permesso al mondo del gin di esplorare diversi metodi produttivi e ingredienti, dando vita ad alcuni tipi riconosciuti di questo distillato. Vediamo insieme quali… Gin Distilled Questi gin sono ottenuti esclusivamente mediante distillazione di alcol etilico a 96% vol/vol in presenza di bacche di ginepro e delle piante aromatiche scelte. Anche in questo caso la gradazione minima è di 37,5% vol/vol. Molti di questi gin in commercio sono aromatizzati successivamente alla distillazione con piante aromatiche o frutti posti in macerazione: in questo modo si dona colore al distillato e un’ulteriore carica aromatica, elementi che andrebbero persi in distillazione. Illustrazione di un Alambicco Fragole, lampone e ribes rosso sono gli aromatizzanti che si ritrovano nel Gordon’s Premium Pink, un distilled gin dal colore rosa brillante. London Dry Gin Il London Gin è ottenuto esclusivamente mediante distillazione di alcol etilico in presenza di tutte le piante aromatiche scelte. Presenta una regolamentazione più stringente, dove viene specificato il limite di metanolo (5 g/hl di alcole a 100% vol/vol), e viene altresì vietato l’utilizzo di coloranti ed edulcoranti. Il ciclo di distillazione deve concludersi con un distillato dalla gradazione minima di 70% vol/vol. In seguito può essere abbassata per la commercializzazione non al di sotto dei 37,5% vol/vol. E’ forse il più classico e il più apprezzato dei gin. Sono iconici il Tanqueray con il suo aroma agrumato, e il Bombay Sapphire delicato e floreale. Compound Gin I Compound Gin sono frutto del blend fra alcolati già pronti e un alcol base. E’ perciò un metodo a freddo, che trova le sue origini nei cosiddetti bathtub gin dei tempi del Proibizionismo. Questi gin di contrabbando erano fatti mettendo in infusione nell’alcol ginepro e spezie, senza passare per la distillazione, ottenendo così un gin “sporco”, non limpido. I contenitori di macerazione erano spesso di fortuna, come appunto vecchie vasche da bagno. Oggi si utilizzano vasche di acciaio in cui vengono miscelati nelle quantità desiderate i vari alcolati, frutto di distillazioni precedenti delle piante aromatiche. Una nuova tendenza dentro questa famiglia di gin è il blended gin, ottenuto dal mix di alcolati di singole piante aromatiche, distillate in discontinuo. Tra i gin compound vale la pena menzionare il Bathtub Gin di Ableforth’s, prodotto ancora nello stile del proibizionismo. Viene prodotto infatti un distillato di ginepro, di cui una parte è utilizzata per mettere in infusione le botaniche fresche. Il risultato è un Gin Compound che esalta particolarmente gli aromi delle erbe aromatiche, senza passarle in distillazione. Plymouth gin Prima della Brexit era l’unica IGT di gin, oggi rimane solo una tipologia di gin in commercio. E’ un gin tradizionale, prodotto nell’omonima città inglese a partire da 7 botaniche, utilizzando un alambicco particolare. Il Plymouth gin è prodotto dalla Black Friars Distillery, unica distilleria rimasta nella cittadina, nonché la più antica del paese. Old Tom gin Questa tipologia è forse la madre di tutte le altre, con il suo gusto dolce dato dalla liquirizia. Oggi si ottiene con una selezione di botaniche distillate a caldo e l’aggiunta di zucchero in percentuale che varia dal 2 al 5%. L’Old Tom di Hayman’s è una riproduzione fedele di questo prodotto molto apprezzato nell’Inghilterra vittoriana. Illustrazione di un Alambicco Sloe Gin Infine questo prodotto che non è propriamente un gin, bensì un liquore a base di gin. Le famiglie inglesi producevano, ciascuna secondo la propria ricetta, questo liquore rosso. Veniva poi offerto a fine pasto, aggiungendo prugnole acidule e zucchero al gin. Il liquore ha una gradazione inferiore a quella del gin, anche se ne conserva la nota intensa e balsamica di ginepro. Oltre alle grandi distillerie, stanno emergendo sul mercato anche prodotti più artigianali e di piccoli produttori. The Spiritual Machine nasce proprio per dare forma alle idee dei nuovi produttori che si affacciano sul mercato, garantendo artigianalità e un’altissima qualità di alcolati e tinture. Se hai uno “spirits nel cassetto”, sia un gin o un botanicals, prenota una consulenza con il nostro team.
Le locandine storiche del Vermouth

Le locandine storiche del Vermouth Se oggi ci sembra di vivere un boom del Vermouth nel mondo dei craft spirits, a cavallo fra ‘800 e ‘900 il fenomeno Vermouth doveva essere una vera e propria bomba atomica. Le fabbriche storiche come Martini&Rossi, Cinzano e Carpano esportavano in tutto il mondo i loro Vermouth e si erano dotate di binari per i treni interni ai propri stabilimenti, tale era il volume di merce in uscita. Il successo dirompente portò anche alla nascita di numerose imitazioni e contraffazioni di questo vino aromatizzato, motivo per cui le aziende investono moltissimo in marketing e branding a cavallo dei due secoli. Nascono così collaborazioni di successo fra artisti e grandi case del Vermouth, che ci consegnano oggi alcune delle locandine pubblicitarie storiche più belle del settore alimentare. Leonetto Cappiello Cappiello per Cinzano (1910) Cappiello per Campari (1921) Leonetto Cappiello, originario di Livorno ma vissuto per un lungo periodo in Francia, fu insieme a Dudovich uno degli artisti più pagati degli anni ‘20. I suoi lavori per Cinzano, Campari e Martini restano delle vere e proprie icone della grafica pubblicitaria, con i loro colori vividi e le immagini plastiche. Cappiello per Martini (1930) Marcello Dudovich Pubblicitario, illustratore e pittore triestino, è uno dei padri del cartellonismo pubblicitario italiano. La sua collaborazione con Carpano e Martini nei primi anni del ‘900 darà vita al celebre manifesto del Bitter Campari, dai toni rossi come il liquore che reclama, e alla dama bianca del Vermouth Bianco, pensato per il mercato femminile. Dudovich per Martini&Rossi (1920) Dudovich per Campari (1901) Achille Luciano Mauzan Illustratore francese, poi trasferito in Italia dove lavorò per tutta la sua carriera con grande successo. La sua collaborazione con Carpano avviene nel 1930, per una pubblicità sul Vermouth di Torino. Mauzan per Carpano (1930) Fortunato Depero Depero per Campari (1930) La grafica pubblicitaria fa un grande balzo di stile con l’ingresso di Fortunato Depero, uno dei firmatari del manifesto dell’aeropittura, anche conosciuto come secondo futurismo. Le illustrazioni abbandonano lo stile liberty per prendere forme futuristiche e dinamiche. Dalla collaborazione con Campari nascono numerose pubblicità, ma anche la creazione della bottiglia monodose del Campari soda, in uso ancora oggi. Depero per Campari (1932) Armando Testa Il grande grafico e pubblicitario Armando Testa crea per Carpano numerose pubblicità, di grande semplicità ma che sono rimaste nella memoria per la loro efficacia e creatività. Una su tutte è la rappresentazione del Punt e Mes, aperitivo con una punta di amaro e mezza di dolce, rappresentate appunto da una sfera e mezzo. Testa è anche l’artefice del personaggio re Carpano, il Re Vermouth rappresentato mentre brinda con i grandi personaggi storici italiani. Armando Testa per Carpano (1963) Armando Testa per Carpano (1964) Le locandine storiche del Vermouth sono solo un piccolo tassello della storia di questo vino aromatizzato, che ha origini ben più antiche che possiamo far risalire fino alla medicina greca. Tutta la storia del Vermouth, i suoi segreti e i suoi personaggi chiave li puoi approfondire sulla nostra Academy, pre-iscriviti per non perdere nulla!
Streghe, pozioni e piante aromatiche

Streghe, pozioni e piante aromatiche L’Autunno spoglia il paesaggio dei colori verdi e brillanti dell’estate, per fare spazio ai colori delle foglie cadute, ai primi freddi e alle atmosfere nebbiose e cupe, preludio dell’inverno: è lo scenario in cui nella credenza popolare si muovono streghe e creature magiche. È la festa dei morti e dei santi, è Halloween: la sera degli spiriti. Le streghe nell’immaginario popolare Nelle borgate dei paesini di montagna e collina, ci si riuniva intorno al fuoco per trascorrere le lunghe serate invernali intenti nei lavori domestici, ascoltando le storie di queste streghe malvagie e dispettose. La strega era solitamente una donna sola, dall’aspetto spaventoso, brutta e gobba, con conoscenze approfondite delle erbe aromatiche, che utilizzava per incantesimi e pozioni. Potevano trasformarsi di notte in animali, come corvi o gatti, motivo per cui è così temuto il famoso gatto nero. Erano responsabili della morte degli infanti, della moria del bestiame, del cattivo raccolto, ma anche di piccoli dispetti come, per esempio, far inacidire il latte o perdere l’ago per filare la lana. Nella realtà erano spesso donne guaritrici, dalla grande conoscenza e maestria nell’uso delle piante, unici medicinali fino all’avvento della scienza moderna. Giravano per i boschi raccogliendo radici, fiori ed erbe spontanee, combinate poi per creare decotti e sciroppi curativi. Ecco che una tintura di genziana contro i vermi o un preparato di ginepro come diuretico, potevano essere interpretati come frutto di stregoneria. Queste conoscenze antiche sono le stesse che hanno poi segnato la nascita della liquoristica e che oggi alimentano con creatività e varietà il mondo degli spirits. Visioni e allucinazione: le erbe aromatiche utilizzate dalle streghe… e non solo Nell’immaginario attuale e soprattutto medievale, le streghe non usavano però le erbe a fin di bene, ma avevano lo scopo di creare pozioni per alterare e stordire le loro vittime. Nei Sabba, ritrovi di streghe e stregoni in presenza del demonio, le pozioni dovevano favorire l’incontro con il demonio, ma gli stessi ingredienti potevano essere usati sui malcapitati bersagli di sortilegi e incantesimi. Erbe allucinogene e potenti sedativi erano però utilizzati nel quotidiano con molta disinvoltura ben prima del Medioevo, come dimostrano i numerosi trattati di medicina antica. La monaca benedettina Ildegarda di Bingen (1098-1179), santa e Dottore della Chiesa, nei suoi trattati di erboristeria elenca sei piante con proprietà psicoattive, comunemente utilizzate come rimedi medicinali: Canapa, Papavero, Assenzio, Mandragora, Belladonna e Giusquiamo. Alcune di queste piante sono ancora oggi ingredienti imprescindibili nella liquoristica, le cui dosi sono severamente normate e controllate. L’assenzio, per esempio, è notoriamente componente amara dei Vermouth, eppure a dosi elevate provoca allucinazioni, a causa di un gruppo di molecole chiamate tujoni. Si pensi che il celebre liquore all’assenzio, anche conosciuto come Fata Verde, in grado di provocare uno stato catatonico e allucinatorio in chi lo bevesse, è stato vietato in molti stati europei tra ‘800 e ‘900, proprio per la sua pericolosità. Allo stesso modo la Canapa, opportunamente lavorata e selezionata per avere percentuali irrisorie di THC, è oggi ingrediente di molti new spirits innovativi, anche se il suo uso psicoattivo è noto sin dal V sec a.C. Gli Infusionist, creatori di spiriti e magia Oggi streghe e stregoni trovano forse un erede nella figura dell’Infusionist, nuovo conoscitore delle piante aromatiche e sperimentatore di pozioni ed elisir. L’innovazione nella creazione di nuovi spiriti, si intreccia con le antiche conoscenze popolari, con le pozioni e gli elisir di lunga vita di cui è disseminata la letteratura. Vecchi e nuovi ingredienti si uniscono per creare spiriti dai sapori esotici, dalle origini mistiche e dalle combinazioni pionieristiche. La congregazione degli Infusionist è grande e in crescita, puoi unirti a loro sulla nostra Community e continuare ad approfondire le “arti degli spirits” sui corsi di Academy. Raggiungi gli Infusionist La community di The Spiritual Machine per i veri intenditori di spirits Clicca qui
Il vino come medicina

Il potere benefico del vino, dalla medicina antica fino ad oggi Il vino, sia di uva che di altri frutti, è sempre stato usato sin dalla sua “scoperta” con scopo medicinale. Il suo contenuto di alcol ne determina infatti due effetti fondamentali per la medicina antica: un effetto sedativo e analgesico, che in assenza di qualunque tipo di medicinale era piuttosto indispensabile; e un’azione solvente, in grado di estrarre principi attivi da erbe e spezie poste in infusione. Non di meno il vino, e altre bevande fermentate come sidro e birra, erano anche sostituti preziosi dell’acqua, la cui salubrità era spesso compromessa, non esistendo gli attuali sistemi di depurazione. Louis Pasteur nel XIX secolo definirà il vino come “la più sana e la più igienica delle bevande”. Nei secoli medici e alchimisti hanno studiato le proprietà di questa bevanda, consegnandoci un grande numero di scritti e trattati. La medicina dell’antica Grecia Il vino è al tempo stesso sacramento e divertimento per l’uomo anziano. Gli è stato dato da un dio come rimedio all’austerità della vecchiaia. Il vino riempie il nostro cuore di coraggio. (Platone) Il padre della medicina occidentale fu Ippocrate di Cos, studioso e grande conoscitore dell’anatomia umana. Fu il primo a separare la figura del medico da quella del filosofo e a rendere sistematico lo studio delle malattie e dei loro sintomi. La sua teoria degli umori fu adottata per molti secoli a venire, conservata e studiata dai monaci amanuensi nelle abbazie di Europa. Ippocrate suggeriva il vino come disinfettante per le ferite, sedativo, corroborante e antipiretico, sempre addizionato di erbe medicinali. Galeno, filosofo e medico, si dedicò allo studio della medicina ippocratica, apportando numerose conoscenze anatomiche, tanto da valergli un posto alla corte dell’Imperatore Marco Aurelio, e nella storia della medicina fino al Medioevo. Si pensi che ancora oggi esistono i cosiddetti “preparati galenici”. Le sue preparazioni a base di vino, gli enoliti, comprendono una vasta tipologia di erbe ma soprattutto di vitigni, a seconda della patologia da trattare. Salvia, cardo, santoreggia e assenzio sono solo alcune delle erbe citate da Galeno. La Scuola Medica di Salerno e Arnaldo da Villanova Nella Scuola Medica di Salerno, la prima e più importante istituzione medica in Europa, lo studio del vino medicamentoso trovò il suo terreno ideale. Arnaldo da Villanova condensò nella sua opera “Trattato sui vini” la sua esperienza e le sue conoscenze. In questo scritto si possono leggere preparati a base di vino per tutti i tipi di malanni: dal vino contro la malinconia a quello per curare la memoria, fino a rimedi contro la febbre o la nausea. Come non menzionare la ricetta del vino all’assenzio, antenato dell’odierno Vermouth? Villanova nel “Trattato sui vini” scrive così: Il vino d’assenzio agisce contro i vermi, i calcoli fetidi e flemmatici presenti nella cavità del corpo e nei luoghi nascosti; disgrega i calcoli, li dissolve, li consuma: conserva proprietà utili per non tollerare eccessi ed espulsive per allontanarli. Un medico lo utilizzava per ogni disturbo sconosciuto, con una ricetta base di succo di assenzio, di rose, di borraggine e di indivie: il composto cancella la viscosità del flusso, conforta la parte per evitare che l’umore si presenti. Faceva cuocere il tutto e definiva il risultato lodevole. Il vino d’assenzio agisce contro i reflussi e i vapori provenienti dallo stomaco, contro l’ostruzione della milza e del fegato, contro l’itterizia, l’apoplessia e l’afonia, contro l’asfissia dovuta a un’intossicazione da funghi e contro il veleno. Il suo uso schiarisce la vista, viene in aiuto allo stomaco e al fegato, dissolve l’urina, alleggerisce il mestruo, conduce l’umore crudo del ventre. Il vino d’assenzio è il rimedio indicato per l’intossicazione da cicuta, giusquiamo, oppio e altri prodotti narcotici; resiste a tutti i veleni, il suffumigio del vino conduce alla sordità per occlusione e se si lavano le ferite con questo vino non ci sarà formazione di fistole né putrefazione della carne; utile anche contro il prurito alterato dal flemma che per sintomo ha la comparsa di pustole bianche e molli. E se si beve prima di imbarcarsi, non si ha nausea né si rimette. Se si consuma in occasione di un’epidemia, ci si può spostare e rendere visita ai malati: l’aria che si respira non presenta alcun pericolo. Certuni bevono il succo crudo dentro del buon vino, in un determinato periodo, affermando che questo è il modo migliore per non essere ammalati durante l’anno. Favorirebbe il sonno, allontanerebbe i tumori, farebbe sparire i dolori. Un decotto di questo vino è un rimedio efficace per i paralitici. Esso è anche valido per i tumori della lingua, e di molte altre cause. La medicina popolare Il vino rimase a lungo un ingrediente della medicina popolare e casalinga, utilizzato per guarire i piccoli disturbi. Usato in combinazione con erbe e frutta era il rimedio ideale per problemi di stomaco, raffreddori e dolori di vario genere. Non bisogna scordare il grande ruolo che questa bevanda ebbe nell’alimentazione: se oggi il vino è un piacere, fino a pochi decenni fa era parte integrante e indispensabile della dieta popolare. Il vino assicurava infatti calorie extra per il duro lavoro nei campi e riscaldava durante i periodi più freddi dell’inverno. La medicina moderna Anche la moderna medicina si è interessata recentemente delle proprietà medicinali del vino, in particolare del suo contenuto di antiossidanti. Forse suonerà familiare il “paradosso francese”, che evidenzia come un alto consumo di grassi animali assunti dalla popolazione francese (formaggi e carni), non risulti in un altrettanto elevato tasso di malattie cardiovascolari. Un tentativo di spiegare questa singolarità ha portato all’attenzione il consumo giornaliero di vino rosso, come possibile protettore del sistema cardiovascolare. Oggi l’attenzione è su una molecola in particolare, che possiamo ritrovare facilmente sotto forma di integratore o anche nei prodotti cosmetici: il resveratrolo. Contenuto anche nei frutti rossi, nei pistacchi e nel cioccolato, oltre che ovviamente nei vini rossi, il resveratrolo è un polifenolo con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Per raggiungere però i livelli utili di questa molecola proposti dai diversi studi
La storia del vino

Le origini del vino, una storia lunga milioni di anni Quando sorseggiamo un buon calice di vino e ammiriamo la bellezza di un paesaggio viticolo, spesso non pensiamo alla storia del vino. Ci sfugge il fatto che stiamo osservando qualcosa che ha una storia di milioni di anni. La storia del vino infatti inizia dalla Preistoria, passa per le popolazioni della Mesopotamia, e arriva fino a noi, attraversando epoche, popolazioni e culture diverse. La vite come noi la conosciamo oggi: la Vitis vinifera e la storia del vino La storia del vino parte dalla sua materia prima, l’uva, e dalla pianta che la produce, la vite. La vite è una pianta straordinaria, capace di adattarsi ai climi più vari. La sua coltivazione è infatti possibile in una vasta area del nostro pianeta, che va dai 30° ai 50° di latitudine nord e sud. Le prime testimonianze archeologiche dell’esistenza di piante del genere Vitis si datano nel Paleocene, circa 65 milioni di anni fa. La vite da vino che conosciamo noi oggi, ovvero la Vitis vinifera è il prodotto di una domesticazione durata migliaia di anni, da parte delle popolazioni preistoriche, che trovarono le prime bacche di cui cibarsi nei boschi e nelle radure. Una prima tipologia di coltivazione si sviluppò solo nel Neolitico quando l’uomo smise di essere cacciatore e raccoglitore nomade e iniziò a stabilirsi in villaggi. Come in ogni insediamento è corretto immaginare la presenza di una sorta di discarica in cui venivano gettati scarti alimentari e altro materiale. In questi immondezzai ricchi di composti e sostanze organiche era molto facile che i semi contenuti negli scarti di cibo germogliassero, dando origine a piantine. La storia del vino e la vite selvatica La vite selvatica era “dioica” ovvero con fiori maschili e fiori femminili su piante distinte. Intuitivamente l’uomo selezionò per prime le piantine in grado di dare grappolini, ovvero quelle femminili. Solo successivamente le piante con fiori ermafroditi vennero protette e coltivate con cura, perché potevano garantire sempre una produzione di frutto, anche in assenza di piante maschili nelle vicinanze, altrimenti necessarie per la fecondazione dei fiori. Questo processo di domesticazione e selezione delle piante più produttive durò per diverse migliaia di anni fino a portare allo sviluppo delle prime zone viticole intorno al 5000 a.C. nella Mesopotamia. La Mesopotamia e l’Egitto Dal 3000 a.C. si hanno testimonianze certe della coltivazione della vite da parte dei Sumeri nella Mesopotamia meridionale, in particolare in piccoli vigneti irrigati all’interno di complessi templari. La maggior parte del vino proveniva tuttavia dalle zone vicine alla catena dei monti Zagros, nell’Iran occidentale, dove la viticoltura era favorita dalla maggior altitudine. È curioso notare come già in epoche così antiche fosse noto che dalle zone montuose e collinari avesse origine un prodotto dalle caratteristiche qualitative migliori. La viticoltura si diffuse poi nel sud-ovest asiatico e nel Mediterraneo Orientale, fino a coinvolgere l’Egitto, ricchissimo di documenti iconografici relativi alla viticoltura, che forniscono numerose indicazioni sulle pratiche agronomiche ed enologiche del tempo. La coltivazione della vite e la lavorazione dell’uva La vite era coltivata in pergolati, sempre dotati di irrigazione a causa del clima caldo e secco. La pigiatura veniva fatta con i piedi in grandi contenitori, dotati di corde a cui gli uomini potevano aggrapparsi durante questa faticosa operazione. Una volta conclusa la fermentazione, le bucce erano poste in una busta di tela attaccata a due corde. Quest’ultime venivano fatte girare per strizzare il succo rimasto, in una sorta di pressa primordiale, ma sicuramente molto efficace. L’industria vitivinicola romana Il viaggio e la diffusione della viticoltura continuarono fino a raggiungere le coste più occidentali del Mediterraneo. In Grecia iniziò la produzione di vini che diverranno particolarmente famosi e apprezzati in età imperiale presso i Romani. Con la fondazione di colonie nella parte occidentale del Mediterraneo intorno al VIII secolo a.C. si aprirono nuove rotte commerciali per i prodotti greci. Anfore ioniche sono state ritrovate in Francia, indicando che la diffusione del vino raggiungeva già l’area della valle della Saône e del Giura. Lo sviluppo e il consolidamento delle colonie italiche favorì l’installazione di nuovi vigneti e il conseguente commercio del prodotto. Questo fu poi esportato e diffuso a nord, fino in Gallia. La Repubblica romana si ritrovò quindi, con l’ampliarsi del proprio dominio, con un patrimonio vinicolo vastissimo e molto variegato, come descriverà poi Plinio nella Naturalis Historia, il primo trattato di ampelografia della storia, la scienza che studia e classifica le diverse varietà di vite. La viticoltura nella villa romana A partire dal II secolo a.C. la coltivazione dell’uva da vino assunse i connotati di una vera e propria industria, soprattutto grazie alle numerose conoscenze tecniche, testimoniate nei molti trattati di agricoltura e proto-enologia del tempo. La villa romana si articolava infatti come una azienda agricola. Era strutturata per un’agricoltura di tipo intensivo: i territori erano dell’ordine delle centinaia di ettari, dislocati in varie zone dell’Impero, e coltivati da eserciti di schiavi e braccianti, motivo per cui il rapporto costi-ricavi non era da trascurare. Inoltre, queste prime aziende vitivinicole erano specializzate nel commerciare i loro prodotti all’estero. Questo è testimoniato dai ritrovamenti archeologici di anfore di forma diversa a seconda della provenienza del prodotto, una sorta di primo riconoscimento di denominazione per evitare contraffazioni. Dal numero di anfore ritrovate si ipotizza un flusso commerciale di 100.000 ettolitri di vino l’anno, in evidente crescita vista la progressiva adozione di anfore di capacità maggiore. La crescita della domanda è da ricercare nella grande ricchezza dell’impero in seguito alle conquiste orientali, e soprattutto ad un importante aumento demografico, con conseguente richiesta maggiore di vino, come attesta la grande concentrazione di osterie a Pompei, Ostia ed Ercolano. L’industria vitivinicola Un’industria così fiorente da dover subire ad un certo punto un controllo di tipo statale. Nel 92 d.C. infatti la superproduzione dell’industria vitivinicola romana costrinse l’Imperatore Domiziano ad emanare in uno specifico editto. Questo impediva l’impianto di nuovi vigneti in Italia e obbligava alla distruzione di una parte nel resto delle Province. Anche nei secoli successivi vennero
Produzione Whisky: le diverse scuole di produzione

Una vera e propria full immersion nella produzione del Whisky! Come si distingue il whisky Irlandese dal parente scozzese? Quali sono i diversi metodi di produzione che danno origine a prodotti molto diversi tra loro? Attraverso questo articolo scoprirai le diverse scuole di produzione ed ancora le varie tipologie di questo distillato: grain whisky, single malt scotch whisky, single malt…iniziamo! Il whisky è un distillato complesso e affascinante, ricco di storia e di tradizione. Acqua, malto e cereali si combinano insieme per essere poi distillati e arrivare al lungo invecchiamento in botti di legno. Esistono diverse scuole di produzione del whisky, ciascuna con le sue peculiarità, capaci di dare origine a prodotti dalle caratteristiche molto diverse fra loro. La Scozia e i suoi single malt Parlando della produzione del Whisky non possiamo che partire dalla Scozia con i suoi single malt. Da questa terra remota e montuosa nasce il whisky per eccellenza, forse il più rappresentativo fra tutti: il single malt scotch whisky. I single malt scozzesi, prodotti esclusivamente con malto, sono apprezzati e conosciuti in tutto il mondo, soprattutto per i tipici sentori di torba, caratteristici delle produzioni delle Isole. La torba tradizionalmente veniva utilizzata come combustibile dalla popolazione locale ed impiegata anche per alimentare i forni per l’essiccazione del malto. Questi erano capaci sia di ridurre l’umidità dell’orzo maltato sia di affumicarlo, apportando profumi che ricordano la salsedine e il catrame. Produzione del Whisky Scozzese: la distillazione La loro distillazione può avvenire solamente in alambicchi discontinui di rame. Solitamente la gradazione finale non supera quasi mai i 70/72 gradi. I single malt invecchiano poi in botti di quercia di capacità pari o inferiore ai 700 litri per un minimo di 3 anni. Il disciplinare consiglia un periodo più lungo fino a 5 anni ma non è obbligatorio. In pratica, se il single finisce in un blend si usa anche il 3 se si vende tal quale meglio 5 o 7, acquisendo sempre maggior pregio e carattere con il progredire dell’invecchiamento. Per assecondare i gusti e le esigenze del mercato ad oggi è possibile effettuare dei blend fra diversi single malt (blended o vatted malt). Storicamente si era soliti mescolare i single malt e whisky di altri cereali in distillazione in colonna ad alto grado, per dare origine alla categoria popolare dei whisky blended. Produzione del Whisky Irlandese L’Irlanda tuttora rivendica la paternità del whiskey, apportando anche una grafia tutta propria per il suo distillato. Il whiskey irlandese si distingue dal parente scozzese per un contenuto minore di malto d’orzo, storicamente pesantemente tassato. I distillatori irlandesi per sfuggire alle imposte del regno d’Inghilterra, utilizzavano infatti in prevalenza orzo non maltato, seppure con una piccola percentuale di malto. Questo è necessario (vale per i whiskey single grain dove ci sono altri cereali e una percentuale piccola di orzo) per una corretta fermentazione degli zuccheri di questo cereale prima della distillazione. Nel whiskey irlandese più tradizionale inoltre, si effettua (anche qui non è obbligatoria a disciplinare) anche una terza distillazione (una in più rispetto al whisky scozzese). Qui è assente la torbatura, anche se si ritrova in alcune produzioni recenti. Questo terzo passaggio dà maggior pulizia e morbidezza ai malti che solitamente hanno anche periodi di invecchiamenti totali più brevi. Nella scuola irlandese raramente si avevano dei single malt. Solitamente si procedeva alla creazione di blend ottenuti con altri cereali, quasi sempre grano o mais, distillati in colonna ad alto grado (94.8). Produzione Whisky Giapponese Dall’Europa spostandosi fino al Sol Levante, non si può non menzionare il whisky giapponese, ormai un prodotto universalmente riconosciuto per la sua qualità e cura nel processo produttivo. La nascita della distilleria “Nikka” Masataka Taketsuru, figlio di grandi produttori di sakè, si trasferì in Scozia per studiare chimica. Erano i primi anni del Novecento e in pochi anni Masataka riuscì a raccogliere tutte quelle preziose informazioni che lo portarono a fondare la sua distilleria in Giappone: la celebre Nikka. Dall’inizio della sua storia ad oggi, il whisky giapponese ha conosciuto una sempre crescente fama, grazie alla qualità indiscutibile della tecnica di produzione sviluppata nel corso degli anni. Questa qualità ha trovato finalmente riconoscimento nella recente redazione del disciplinare di produzione del whisky giapponese, in vigore dal primo aprile 2021. Approvato il disciplinare per la produzione del Whisky Giapponese Per chiamarsi “japanese whisky” la Japan Spirits and Liqueurs Makers Association ha stabilito che l’intero processo produttivo debba essere svolto sul territorio del Giappone. Allo stesso modo la totalità delle materie prime (acqua, cereali maltati e non) deve essere di origine nipponica. L’invecchiamento minimo è della durata di 3 anni, e deve avvenire in botti di legno dalla capacità pari o inferiore ai 700 litri. Per essere imbottigliato il whisky deve avere gradazione di almeno 40% vol/vol. E’ consentito l’utilizzo di caramello come colorante per uniformare le diverse partite. Fino al 31 marzo 2024 ci sarà una fase di transizione. I produttori potranno adattarsi alle nuove disposizioni poiché spesso i malti da fermentare erano acquistati direttamente in Scozia. La costituzione di questo disciplinare rappresenta una grande svolta e riconoscimento per questo prodotto. Infatti, la produzione era prima “libera” ovvero a discrezione delle varie distillerie, e soprattutto a rischio contraffazioni. E’ pur vero che il mercato e i consumatori avevano già da tempo riconosciuto il valore di questo prodotto. Emblematica, già nel 2011, fu la vendita all’asta di una bottiglia di Yamazaki invecchiato di 50 anni, per la bellezza di 300.000 dollari, prezzo che non ha nulla da invidiare a quello di alcune storiche produzioni scozzesi. Il Whisky Canadese e il Proibizionismo americano La storia del whisky Canadese è indissolubilmente legata a quella del Proibizionismo americano. Non è un caso che alcune delle più grandi distillerie sorgessero proprio in Ontario, lungo il fiume Detroit, posizione ideale per contrabbandare fiumi di whisky negli assetati Stati Uniti. Spesso inoltre le materie prime, tra cui gli alambicchi e partite di whisky pregiato, venivano acquistate a poco prezzo dalle distillerie americane in piena crisi economica. Produzione del Whisky Canadese Ad oggi il whisky canadese è ottenuto per la maggior